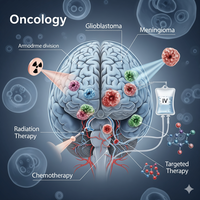Le malattie rare sono patologie che colpiscono un numero limitato di persone, ma che, nel loro insieme, rappresentano una sfida significativa per la sanità pubblica globale. Spesso di origine genetica, queste condizioni sono complesse e richiedono un approccio diagnostico e terapeutico altamente specializzato. Il nostro lavoro si concentra sulla ricerca e l’innovazione per migliorare la vita delle persone affette da queste patologie, con un’attenzione particolare a condizioni come la malattia di Fabry, la malattia di Pompe e la malattia di Gaucher.
Le basi genetiche e le sfide diagnostiche
La maggior parte delle malattie rare, incluse quelle lisosomiali come la Fabry, la Pompe e la Gaucher, è causata da mutazioni genetiche che alterano il funzionamento di specifici enzimi o proteine. Questi difetti genetici portano all’accumulo di sostanze dannose all’interno delle cellule, causando danni progressivi a organi e tessuti.
La principale sfida è la diagnosi precoce. A causa della rarità di queste condizioni e della variabilità dei sintomi, i pazienti spesso affrontano un lungo e difficile “odissea diagnostica”, che può ritardare l’inizio di una terapia efficace. La nostra ricerca si impegna a sviluppare metodi diagnostici più rapidi e precisi, come il sequenziamento genetico e il riconoscimento di biomarcatori specifici.
Approcci terapeutici innovativi
Una volta effettuata la diagnosi, la ricerca si concentra sullo sviluppo di terapie mirate. Le malattie lisosomiali, in particolare, hanno beneficiato di approcci terapeutici innovativi:
- Terapia di Sostituzione Enzimatica (ERT): è un trattamento che mira a rimpiazzare l’enzima mancante o non funzionante somministrando una sua versione ricombinante. È un approccio terapeutico efficace e consolidato per la malattia di Fabry e la malattia di Gaucher, riducendo l’accumulo di substrato e alleviando i sintomi. Anche per la malattia di Pompe la ERT ha rivoluzionato il trattamento, migliorando significativamente la funzione muscolare e la sopravvivenza.
- Terapia Genica: rappresenta la frontiera più avanzata. Si propone di correggere la causa della malattia inserendo una copia corretta del gene difettoso nelle cellule del paziente. Questa strategia ha il potenziale per offrire una cura definitiva in un’unica somministrazione.
- Farmaci chaperone: queste piccole molecole sono progettate per stabilizzare l’enzima difettoso, aiutandolo a raggiungere il suo corretto sito d’azione e ripristinare parzialmente la sua funzione. Sono un’alternativa terapeutica, in alcuni casi, per determinate mutazioni.
L’impegno nella ricerca sulle malattie rare non è solo un dovere etico, ma anche un’opportunità scientifica. Le scoperte fatte in questo campo spesso hanno un impatto più ampio, svelando meccanismi biologici fondamentali che possono essere rilevanti anche per malattie più comuni. Continuiamo a lavorare per tradurre la ricerca scientifica in speranza e soluzioni concrete per i pazienti e le loro famiglie.